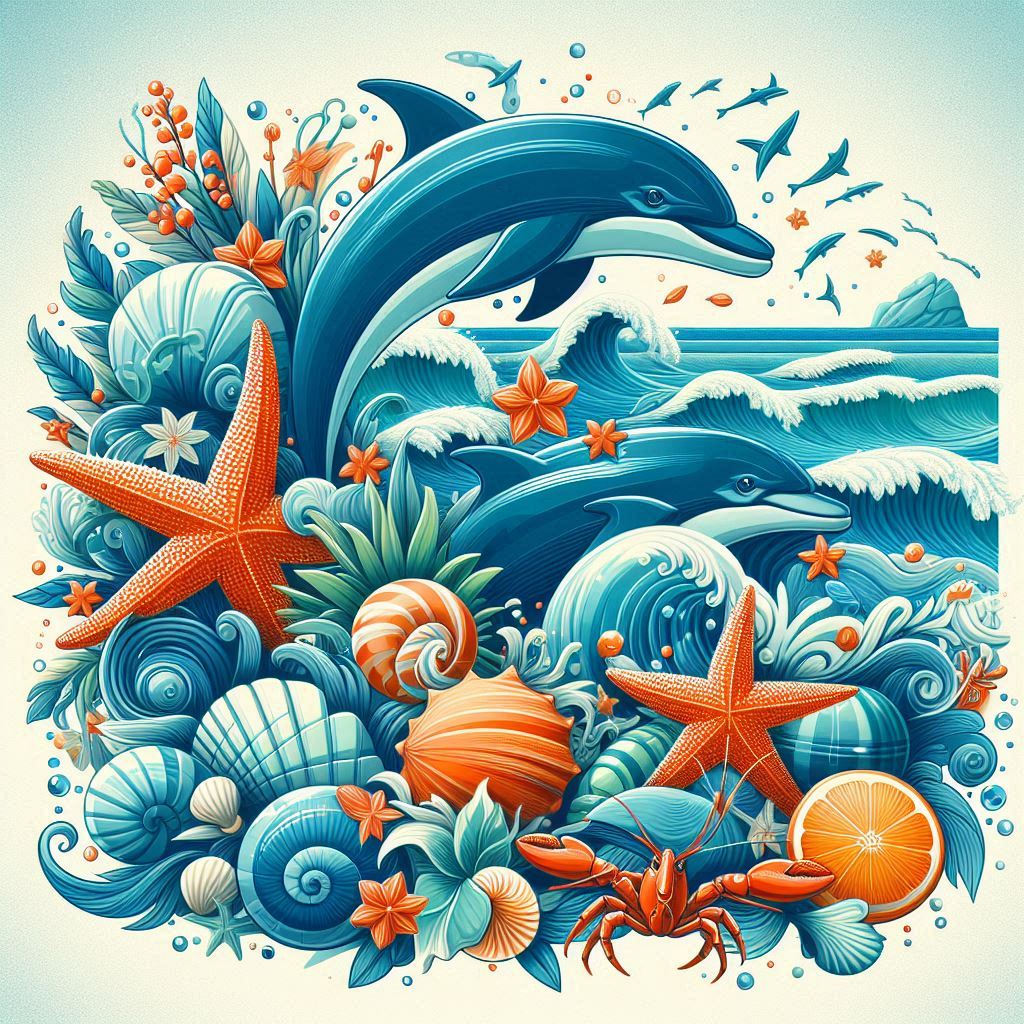Le incerte origini di Segesta – uno dei luoghi in assoluto più affascinanti della Sicilia – sono genericamente fatte risalire all’epoca preistorica. Tucidide e Virgilio narravano che su questo lembo di terra proteso verso il mare approdò Enea al termine della guerra di Troia e che la stirpe dell’eroe sconfitto da Achille si unì a quella della popolazione locale, gli Elimi. E Segesta, con Erice ed Entella, fu uno dei tre centri principali del popolo elimo, diventandone presto la città più potente.
La storia di Segesta si incrocia, in un rapporto spesso conflittuale, con quella della rivale Selinunte, coinvolgendo nelle guerre le città di Atene, Siracusa e Cartagine: i primi sconti si ebbero a partire dal 580 a.C., ma solo nel 409 a.C. Selinunte venne distrutta. Tornata all’indipendenza dopo essere stata conquistata da Siracusa e all’amicizia con Cartagine, Segesta fu alleata di Pirro e, nel 260 a.C., passò ai Romani. Sul destino della città in età romana si sa nulla, anche se c’è notizia di una distruzione di Segesta ad opera dei Vandali.
La città sorgeva su un vasto altopiano dominato dalle due cime della collina di monte Barbaro (431 e 415 metri sul livello del mare) ed ebbe il suo periodo di maggiore importanza tra il VI e V sec. a.C.
All’interno del perimetro urbano, l’unico edificio noto è il teatro, mentre nelle immediate vicinanze sorgono due grandi edifici sacri, il tempio non finito e il grande santuario arcaico e classico in contrada Mango. Per quanto grandioso e stupefacente, ciò che rimane oggi è solo un’ombra dei fasti di un tempo.
Il teatro è un incredibile edificio in buono stato di conservazione, notevole esempio di una struttura teatrale considerata come uno dei tipi di “passaggio” tra teatro greco e teatro romano.
La forma della cavea è semicircolare con prolungamenti rettilinei in direzione dell’edificio scenico. La cavea, con i sedili tagliati nella pietra, apre su un emozionante scorcio verso il blu infinito del mare.
La data di costruzione del teatro viene in genere fissata intorno alla metà del III sec. a.C., tuttavia successive scoperte la datano con molta probabilità verso la metà del IV sec. a.C., una datazione più in armonia con ciò che si conosce della storia politica e con il probabile svolgimento delle fortune della città.
Sotto la cavea è stata rinvenuta una grotta con materiali preistorici, mentre sparsi sul pendio, giacciono i resti di una chiesa del Quattrocento, di una moschea e di un castello del XII sec., di antiche mura e di numerose abitazioni, sedimento di una lunga ed emozionante storia, che continua con le rappresentazioni che ancora oggi si effettuano nel teatro.
Il grande tempio dorico è il più celebrato monumento di Segesta e si inserisce in un modo meravigliosamente affascinante nel paesaggio e nel panorama della zona.
Imponente e superbo nelle sue linee doriche, fu eretto verso la metà del V sec. a.C. e si presenta come un portico a colonne (6×14 colonne per circa 21×56 m) che recinge l’esterno di un edificio, su un basamento di tre gradini e coronato da architrave e fregio e, sulle due fronti, da bassi timpani.
Il tempio è, con tutta evidenza, una struttura incompiuta (forse proprio a causa dei continui scontri con Selinunte) e non, come si pensava inizialmente, un edificio adibito a un misterioso culto indigeno a cielo aperto.
Questa sua caratteristica di tempio non finito e l’eccezionale stato di conservazione – quello di Segesta è tra i meglio conservati di tutta l’antichità – lo rendono unico e ne hanno fatto da sempre argomento di studio e di interesse per gli archeologi e di particolare ammirazione per il pubblico.
Il santuario in contrada Mango si raggiungeva con due vie antiche che collegavano l’abitato all’area sacra extra urbana. Il santuario è di proporzioni notevoli, un’area grande circa 83×47 metri, ed è certo che all’interno vi sorgessero più edifici, visti i ritrovamenti di muri, colonne, capitelli dorici ascrivibili al VI sec. e al V sec. a.C., ecc.
Tuttavia, nulla si sa del culto praticato e delle divinità venerate all’interno del santuario. Il testo delle centinaia di iscrizioni graffite nella lingua degli elimi, infatti, chiarisce l’appartenenza della lingua al ceppo indoeuropeo (senza però consentire di precisare la natura della struttura linguistica), ma non fornisce indicazioni sulla natura del culto.